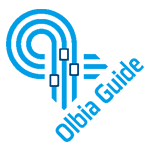NECROPOLI SAN SIMPLICIO
INTRODUZIONE – STAZIONE 1
TESTO
Benvenuto nell’area archeologica di San Simplicio. Questa audioguide è stata realizzata dalla Aspo spa; narrazioni audio a cura di Audio Cultura, testi e consulenza scientifica a cura della dott.ssa Letizia Fraschini.
Per iniziare il percorso di visita raggiungi la fine del corridoio e percorrilo a ritroso ascoltando man mano i contributi audio proposti. Ogni punto di interesse è contrassegnato da un etichetta con il simbolo delle cuffie e il numero corrispondente.
Come ulteriore supporto alla visita puoi consultare i pannelli informativi presenti lungo il percorso.
STAZIONE 2
TESTO
Ci troviamo sotto la piazza della chiesa di San Simplicio, ove è visibile parte dello scavo archeologico eseguito in occasione dei lavori di riqualificazione dello spazio antistante la chiesa.
Lo scavo ha interessato l’intero volume dell’area che stai visitando e parte del parcheggio adiacente, restituendo 450 tombe e una stratificazione di fasi di culto extraurbano e necropoli che percorre i primi 2000 anni di storia della città di Olbia, dalla sua nascita con i Fenici fino al Medioevo.
Il rilievo sul quale oggi sorge la chiesa di San Simplicio è sempre stato nell’antichità al di fuori dell’area urbana.
Le indagini archeologiche indicano con grande chiarezza che al di sotto dell’attuale chiesa giace una stratificazione di luoghi di culto precedenti: prima probabilmente fenicio, poi greco, punico, romano e paleocristiano. In età romana la necropoli, che nel periodo punico era ubicata a sud-ovest rispetto al luogo nel quale ci troviamo, si espande fino ad occupare lo spazio attorno al luogo di culto.
È probabile che un luogo di culto dedicato ad una divinità femminile, forse la dea Ashtart (pronuncia Asctàrt, con la sc dolce come in scìa), fosse già presente con la nascita dell’abitato fondato dai Fenici intorno al 775-750 a.C., visto il ritrovamento di frammenti di anfore fenicie in questo scavo.
Il tempio esisteva di certo durante la fase greca di Olbia, quando i Greci della città di Focèa, sulle coste dell’attuale Turchia, si sostituiscono ai Fenici nell’insediamento urbano intorno al 630 a.C.
Alla fase greca del santuario, dedicato alla dea Dèmetra o alla dea Hera (pronuncia Era) , sono relativi due pozzi per l’acqua, sul fondo dei quali, al momento dell’abbandono verso il 600 a.C., sono state deposte varie offerte con modalità di rituale sacro.
Il primo pozzo lo vedi di fronte a te, con i materiali da esso provenienti: un’anfora vinaria dalla città greca di Clazomène (sulla costa dell’attuale Turchia), una vaso da vino con bocca lobata, un vaso per acqua a fasce di vernice nera, un piccolo vaso prodotto in argilla locale ed un’anfora vinaria etrusca. Il secondo pozzo greco lo vedrai più avanti.
Il santuario quindi sorgeva sul primo rilievo naturale al di fuori dell’abitato. L’uso di appropriarsi simbolicamente del territorio circostante, installando santuari nei luoghi significativi come alture, guadi, promontori, è tipico dei centri urbani coloniali fondati dai Fenici e dai Greci nel Mediterraneo occidentale. Perciò è probabile che anche Olbia, prima fenicia e poi greca, fin dalla sua nascita avesse dignità di città.
STAZIONE 3
TESTO
Con la conquista cartaginese della Sardegna, verso il 510 a.C. anche Olbia passa in mano di Cartagine.
Per la fase punica non sono emerse dallo scavo chiare testimonianze, ma la continuità del santuario nella successiva età romana, rende plausibile l’ipotesi della non interruzione della sua attività anche nella fase cartaginese.
Con la conquista romana della Sardegna intorno al 238 a.C., Olbia vive un momento di grande favore. Siamo in età romana repubblicana e dal 200 a.C. si assiste ad una notevole esplosione economica ed anche demografica e perciò la necropoli della città si amplia invadendo anche le pendici della collina sulla quale sorgeva il santuario. In questa fase la divinità alla quale il culto è dedicato è Cèrere, la Dèmetra dei Greci, divinità della vita e in tale contesto della vita oltre la morte.
L’area inizia a popolarsi di tombe a fossa, che vedi di fronte a te, e che, con il passare del tempo, diventano sempre più numerose.
Come vedi, le tombe sono solitamente accompagnate da corredi funebri composti da una coppia di boccali e brocche e non mancano frammenti di statuette di terracotta della dea romana Cerere.
Da ora e per tutta l’età romana, le tombe si faranno più numerose via via che ci si avvicina al tempio. Naturalmente nelle tombe a fossa non sono esposte le ossa degli inumati, in quanto asportate durante lo scavo e in fase di studio.
STAZIONE 4
TESTO
Di fronte a te vedi ancora le tombe a fossa della fase romana repubblicana.
In età imperiale prosegue il seppellimento dei defunti nelle vicinanze del santuario. Si tratta per lo più di tombe a fossa, alla cappuccina e a incinerazione in vaso, il cui scavo comporta la totale asportazione e perciò ora non sono più visibili.
L’affollarsi di tombe, vicinissime e sovrapposte, testimonia la grande devozione per la dea Cerere: tutti desiderano essere seppelliti vicini al suo tempio. Le sepolture sono così numerose che la quota della necropoli man mano si innalza fino a quella delle tombe a cassone di età imperiale, una delle quali è visibile di fronte a te: vedi il muretto che delimitava la tomba, sulla massa di terra che non è stata scavata per non doverlo distruggere e che restituirebbe, se la scavassimo, alcune sepolture a fossa.
Sempre di fronte a te, in primo piano, è stata ricostruita per scopi didattici una tomba alla cappuccina, in realtà rinvenuta a quota superiore: il cadavere, col suo corredo funebre, veniva protetto con tegole poste a tetto. In questo caso due tegole recano il bollo dell’officina che le produceva, posseduta da Atte, schiava liberata e concubina di Nerone, proprietaria ad Olbia appunto di una fabbrica di laterizi e di latifondi donati a lei dall’imperatore.
STAZIONE 5
TESTO
Le vetrine custodiscono una scelta dei materiali dello scavo restaurati grazie al contributo dell’amministrazione comunale di Olbia.
Nella prima alcuni contenitori ceramici del corredo funerario di tombe d’età romana imperiale. Al centro un tegame da cucina e vasi per bere; in alto a destra riproduzioni miniaturistiche di vasi per bere e contenitori di unguenti profumati; in basso a destra contenitori di unguenti profumati; in basso a sinistra due lucerne; in alto a sinistra un contenitore di unguenti profumati.
STAZIONE 6
TESTO
In primo piano a destra sono visibili due piccole anfore poste in verticale. Si tratta di sepolture a incinerazione: il cadavere veniva bruciato e le poche ossa residue venivano seppellite entro vasi di varia forma. Anche queste, come la tomba alla cappuccina vista prima, sono state rinvenute in realtà a quota superiore rispetto a quella attuale, e poste qui a scopo didattico.
A sinistra di fronte a te, vicino al muro di fondo del sito, è visibile il secondo pozzo della fase greca di Olbia, illuminato con luce interna bianca. Come nel primo caso, sul fondo sono stati rinvenuti vasi deposti con modalità di rituale sacro ora esposti a fianco del pozzo: due grandi anfore da olio o vino da Corinto, una delle quali ricomposta completamente, un’anfora vinaria dall’isola di Chìos (di fronte alle coste dell’attuale Turchia) con le tipiche fasce a pittura rossa, un vaso per versare vino.
A sinistra del pozzo ancora tombe a fossa di età romano repubblicana, e a quota superiore una porzione di una tomba alla cappuccina di età imperiale successivamente tagliata da un muro.
STAZIONE 7
TESTO
In questa vetrina alcuni oggetti da corredi di tombe d’età romana imperiale: una lamina di piombo con figura umana schematica incisa, i chiodi delle suole di due calzari e, da tombe infantili, bamboline con arti mobili e due fischietti in forma di gallina e colomba. Le statuette provengono invece dalle tombe a fossa d’età romana repubblicana già viste prima.
STAZIONE 8
TESTO
Sappiamo che il tempio di Cerere fu ristrutturato verso il 60-70 d. C da Atte, la concubina alla quale Nerone aveva donato vaste proprietà nel territorio di Olbia e che era molto devota alla dea. L’intervento edilizio è testimoniato dall’iscrizione apposta sull’architrave del tempio, rinvenuta nel Medioevo molto probabilmente durante i lavori di costruzione della chiesa di San Simplicio, e subito trasportata a Pisa, ove è tuttora conservata.
Pochi anni dopo, durante il regno degli imperatori della dinastia Flavia, e cioè Vespasiàno, Tito e Domiziàno, si monumentalizzò l’accesso al santuario, realizzando i due lunghi muri paralleli ora visibili, che fiancheggiavano una rampa di accesso al tempio. Se non esistesse il muro di fondo dell’area archeologica, nello spazio inquadrato tra i due muri paralleli potremmo vedere, a quota superiore, l’ingresso della chiesa di San Simplicio perfettamente in asse con i muri romani. Questo allineamento esatto tra i muri romani e la chiesa è un’ulteriore prova del fatto che essa sorge sui precedenti luoghi di culto.
STAZIONE 9
TESTO
Il piano pavimentale della rampa di accesso, del quale rimane ancora qualche traccia, realizzata sotto la dinastia Flavia, coprì due tombe monumentali più antiche, forse puniche, purtroppo già saccheggiate nell’antichità, realizzate in grandi lastre di pietra a destra del lungo muro di sinistra.
Con la progressiva diffusione del cristianesimo, dopo il 313 d.C. al culto della dea Cerere si sostituisce nel santuario quello del martire Simplicio.
I secoli dell’Alto Medioevo, dal 450 al 1000 circa d. C., sono un periodo di grande crisi per Olbia, e perciò in questa fase le sepolture sono poche e molto povere: si tratta di tombe in fosse a volte bordate da poche pietre e prive di corredo.
Per una rinascita culturale ed economica della città bisogna attendere quello che in Sardegna è detto periodo giudicale, quando l’Isola è suddivisa in quattro regni, detti Giudicati, e Olbia è capitale di uno di essi: il Giudicato di Gallura.
In questa fase, siamo nel 1100 d.C., viene eretta la chiesa romanica di San Simplicio tuttora esistente sulla piazza soprastante al sito archeologico.
Per la costruzione della chiesa venne realizzata una fornace per la calce, che è la struttura muraria circolare di fronte a voi posta tra i due muri romani dell’accesso al santuario ed illuminata con luce bianca interna. Essa era necessaria per la realizzazione della chiesa e per successive esigenze edilizie gestite dall’autorità ecclesiastica.
La fornace venne realizzata in questo punto perché era quello a quota più bassa, trattandosi della rampa di accesso al santuario, mentre al di là di essa la quota di calpestio era maggiore a causa del continuo aggiungersi di tombe nei secoli precedenti
L’età giudicale è testimoniata anche da due tombe.
Una, in lastre di granito, è tra la fornace e la base del muro di fondo dell’area archeologica, tra i due lunghi muri romani dell’accesso al santuario, illuminata con luce interna bianca.
L’altra fu realizzata con muretto di mattoni al di sopra del lungo muro romano di sinistra; poiché sfiora quasi la copertura dell’area archeologica, di essa si può apprezzare solo un parte del muro di mattoni nel punto nel quale il muro romano incontra la parete di fondo del sito.
STAZIONE 10
TESTO
In questa vetrina alcuni contenitori di vetro da tombe d’età romana imperiale. Al centro fiale per contenere unguenti profumati e frammenti di una brocchetta; in alto a destra frammenti di contenitori di unguenti profumati a forma di pigna; in basso a destra frammenti di una brocchetta; in basso a destra piccoli vasi per bere; in alto a sinistra un bicchiere e una fiala.
STAZIONE 11
TESTO
In questa vetrina alcuni gioielli e ornamenti personali dal corredo funerario di tombe d’età romana imperiale, due contenitori in piombo per piccoli oggetti o unguenti per cosmesi e, al centro, due specchi di bronzo.
Di particolare rilievo un unico ricco corredo di anelli e gioielli, da una tomba perciò denominata convenzionalmente “del Signore degli Anelli”, tra i quali spiccano un anello con una gemma in corniola, sulla quale è incisa una figura umana, montato in argento, e un disco d’argento con la figura equestre dell’imperatore Costantino.
STAZIONE 12
TESTO
Sono qui visibili due tombe a cassone col loro corredo e due tombe alla cappuccina d’età romana imperiale, queste ultime non scavate per mostrare al visitatore come vengono ritrovate al momento della scoperta. Nella massa di terra non scavata, sulla quale sono le quattro tombe, si celano di certo svariate altre sepolture a fossa.
Le tegole appoggiate sulla parete sinistra dell’area archeologica sono le meglio conservate tra quelle che coprivano le tombe alla cappuccina ritrovate.
Come avrai notato il sito è di non facile comprensione, perché sono visibili contemporaneamente reperti, tombe e strutture murarie che si distribuiscono in un arco temporale di circa 1700 anni. E tuttavia la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e il Comune di Olbia, con fondi della Comunità Europea e della Regione Sardegna, hanno deciso di rendere fruibile questo sito archeologico sia per la sua spettacolarità, sia perché testimonia l’intera storia antica della città, sia affinché gli abitanti e i visitatori abbiano una visione concreta del fatto che a pochi centimetri sotto gli attuali piani di calpestio giace una intera città antica, che ogni lavoro di scavo, anche minimo, mette a rischio.
STAZIONE 13
TESTO
La visita al sito è terminata ma abbiamo altre informazioni per te.
Se già non lo hai fatto, ti invitiamo a visitare la chiesa di San Simplicio sulla piazza al di sopra di questo sito archeologico. Potrai così cogliere altre due importanti prove dell’esistenza di luoghi di culto più antichi celati nel suo sottosuolo. Le tre navate sono separate da due file di colonne alternate a pilastri a base quadrata o rettangolare; noterai facilmente che la base dei pilastri poggia non direttamente sul pavimento della chiesa ma su blocchi che sporgono da esso, e che quindi appartengono a un edificio monumentale precedente. Inoltre, l’ingresso della grande maggioranza delle chiese di questo tipo in Sardegna, e non solo, guarda verso ovest, mentre nel nostro caso guarda verso est, come i templi greci e romani, dei quali quindi ha conservato l’orientamento perché appunto edificata su un luogo di culto pagano.
Ti invitiamo infine a visitare il Museo Archeologico sul lungomare, con gli straordinari relitti di navi romane, e gli altri monumenti aperti al pubblico nel territorio di Olbia: il nuraghe di Càbu Abbas, il pozzo sacro nuragico di Sa Testa, la tomba di giganti di Pèdres, le mura puniche in via Torino, l’isolato abitativo punico e i pilastri dell’acquedotto romano in via Nanni, l’acquedotto romano in via Mincio, il castello di Pedres, la chiesa ottocentesca in via Antonio Spano
Ti ringraziamo per la visita